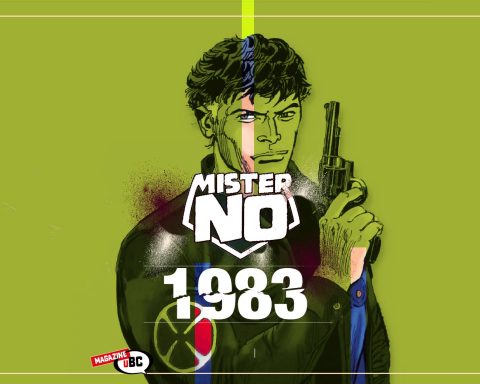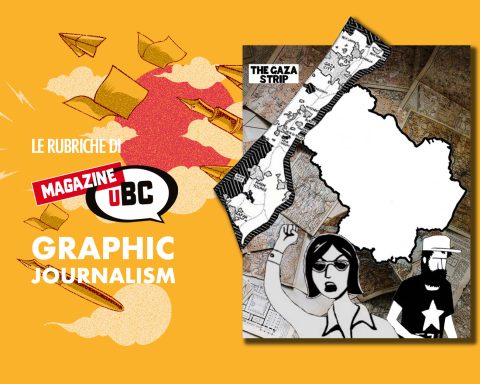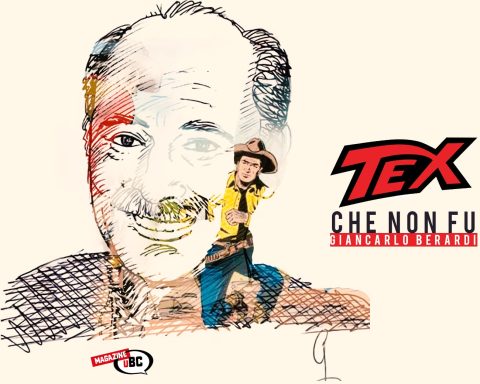Negli ultimi, troppi anni quella di Tex è diventata una testata sempre più anomala, bizzarra: con il tempo, infatti, è progressivamente aumentato – fino a divenire prevalente, e infine pressoché totalizzante – il numero delle “storie con Tex” rispetto a quello delle “storie di Tex”. La differenza è forse sottile (non lo è, ma visto il numero di lettori che sembrano inavvertiti della cosa dobbiamo assumere paradossalmente che lo sia), e probabilmente non viene percepita chiaramente da tutti, ma si tratta di una differenza determinante: è stato narrando “storie di Tex”, ovvero racconti costruiti attorno alle caratteristiche del personaggio come era venuto individuandole negli anni, infine giungendo a strutturarle nel ritratto di una personalità coerente unica e fortemente riconoscibile, che Giovanni Luigi Bonelli ha edificato sulla figura eterodossa e anticonformista del suo Texas Ranger il maggior successo editoriale italiano a fumetti. Storie che furono elaborate secondo quelle caratteristiche, e create esattamente per quel personaggio – dove “quel personaggio” assume volentieri il senso del suo universo narrativo, ugualmente strutturato nel corso degli anni: i suoi storici “pards”, ovvero Kit Carson, Tiger Jack e il figlio Kit Willer, nonché un ristretto nucleo di altri personaggi più o meno ricorrenti e che hanno finito per comporne la genealogia mitologica, e – soprattutto – un set di strumenti narrativi, di regole non scritte ma palesi, che più di ogni altra cosa definiscono chi sia Tex – e spiegano il perché del successo enorme che ebbe e la cui rendita perdura ancora oggi, sebbene ridotta a mera frazione di un tempo. Regole, o più correttamente accorgimenti, che ad esempio esigerebbero che Tex non venisse messo in condizione di dover operare scelte in contrasto con il suo personaggio, come fu in uno dei “peccati originali” di questo percorso di snaturamento in atto con sempre maggiore intensità, ovvero la celebre scena nella storia Il segno di Cruzado del Tex sudato e incapace di risolversi a porre fine alle sofferenze di un indiano morente che lo implora di ucciderlo; la scena venne ideata ovviamente da Guido Nolitta, a cui tutti noi lettori bonelliani siamo debitori di un monumento a imperitura memoria, ma che purtroppo dimostrò di non aver mai compreso davvero la natura profonda del personaggio creato da suo padre, e che proprio con storie come quella di Cruzado aprì la via alla riscrittura di Tex dalle sue fondamenta, fino all’alluvione degli ultimi dieci anni circa.
Appunto Nolitta, con il suo Tex “sbirro” e “giustiziere”, lontano dall’umanità bonelliana apparentemente semplice ma in realtà profonda e fatta tutta di sottintesi, glissati e strategici accenni, e poi Claudio Nizzi, con il suo ranger sempre più incapace – “piccione”, direbbe lo stesso Tex del personaggio cui lo ridusse l’erede designato di GLB – e i suoi raccontini per lo più gialli all’acqua di rose, posero le basi per quella che molti anni più tardi diverrà una vera e propria riprogrammazione in versione “ultimate” del personaggio.

Tra la seconda metà degli anni ’90 e la prima metà del decennio successivo, nel corso della parabola sempre più vertiginosamente discendente della scrittura nizziana di Tex, tra gli ultimi bagliori (o meglio abbagli) nolittiani ed esperimenti che avrebbero meritato migliore accoglienza da parte dell’editore, si inserì il lavoro di Mauro Boselli, che nell’arco di una decina d’anni circa dalla pubblicazione della sua folgorante storia d’esordio, Il passato di Carson, scrisse racconti che restituirono ai lettori un vecchio amico, e a quel vecchio amico la sua identità reale, interpretata secondo una sensibilità aggiornata ma congruente all’originale. Le storie narrate da Boselli in quella decina d’anni furono più che uno spiraglio: rappresentarono una rinascita concreta del personaggio. Con il tempo, tuttavia, la scrittura boselliana prese altri percorsi. A seguire un progressivo declino stilistico, probabilmente imputabile a un’usura da iperproduzione, nel corso del secondo decennio del secolo, e poi con fortissima accelerazione in questo terzo, Boselli ha messo mano a quella versione “ultimate” a cui si accennava. Laddove Bonelli padre era stato estremamente parco di dettagli sul passato e la vita personale di Tex (scolpendo tuttavia quei pochi elementi nel marmo della memoria e dell’immaginazione dei lettori), Boselli ha progressivamente sovrascritto la biografia bonelliana di Tex, arrivando perfino a ideare un nuovo destino finale per il peggior assassino di Lilyth, rimodellando secondo nuove coordinate quello che era stato uno degli ultimi capisaldi in ordine di tempo della “mitologia” fondante di Tex (e facendo fare retrospettivamente al personaggio una figura degna del “piccione” nizziano). Quali che siano le motivazioni dietro questa e le moltissime altre scelte consimili, in particolare quella di (co)stipare una serie costitutivamente libera da pastoie storiche con un retroterra e un’aderenza storici sempre più stringenti, pedanti e restrittivi, l’universo narrativo texiano ne esce profondamente mutato, pressoché irriconoscibile rispetto al modello giellebonelliano. Una scelta legittima, sia chiaro, da parte dell’editore e del curatore del personaggio, ma che non si capisce perché venga negata oltre ogni evidenza delle storie pubblicate.
Alla corrente principale di questo restyling da parte del curatore si aggiunge, sempre più di sovente da parte dello stesso Boselli (ma più ancora di altri autori che lo hanno affiancato) la scrittura di storie nelle quali Tex opera, quando va bene, più da supporting character che da protagonista, storie che per la loro struttura narrativa si intuiscono pensate per un diverso personaggio protagonista, e nelle quali il ranger è inserito per pura necessità editoriale: sono le sempre più frequenti “storie con Tex” di cui si parlava, racconti che – se possibile – sovvertono perfino in modo più grave la natura di base del beniamino del fumetto italiano, un personaggio che nasce per essere mattatore, e vivere storie che ruotano attorno a lui.

Nell’àmbito di questa tendenza, il compianto Gianfranco Manfredi si è mantenuto in genere in una zona grigia, ambigua, scrivendo solitamente un tipo di storie lontane dal mondo texiano, ma mantenendo per lo più la centralità di Tex e rispettandone le caratteristiche in modo accettabile, fornendo ai lettori storie mai banali. Dal canto suo, Tito Faraci è rapidamente naufragato nell’ideazione di esili trame d’abitudine ruotanti attorno ad amici e “pards” creati alla bisogna, fornendo una sola prova degna della storia del personaggio, il Texone scritto per i pennelli di Enrique Breccia: in quel volume, probabilmente stimolato dalla prospettiva di collaborare con uno dei più grandi disegnatori viventi, Faraci ha scritto una storia senza dubbio eccentrica rispetto agli stilemi di Tex, e gestendo bene il compito – arduo e preferibilmente da evitare – di contemperare la verità storica con le particolarità dell’universo narrativo del personaggio ha offerto al lettore un racconto dolente, crepuscolare, reso memorabile dalla visione grafica di Breccia, una “storia con Tex” che tuttavia il lettore del ranger può leggere con lo stesso piacere di una grande “storia di Tex”.
Curiosamente, le migliori “storie con Tex” sono state realizzate da un autore che, con ogni probabilità, conosceva assai poco del personaggio e delle sue caratteristiche, né si interessò particolarmente ad approfondire le sue conoscenze: guidato solo dal suo istinto di narratore di razza, il grande fumettista spagnolo Antonio Segura calò il nostro ranger in un suo West sporco e brutale, essenziale, nel quale un personaggio con il volto e il nome di Tex si muoveva da padrone. È indubbio che in alcune occasioni questa sorta di inconsapevolezza di Segura sia sfociata in storie che di Tex avevano davvero poco, e fatalmente erano anche poco consistenti come racconti; tuttavia, in più di un’occasione quel puro istinto fu sufficiente per realizzare degli albi molto belli, con un personaggio che il lettore accettava facilmente per Tex, e in un paio di occasioni Segura confezionò il capolavoro degno della sua fama: poco importa se con Tex o di Tex.
È però di pacifica constatazione che ad affermarsi nel tempo come lo specialista principe di queste narrazioni “eretiche” sia stato Pasquale Ruju. Da tempo, infatti, quasi di regola le trame ideate da Ruju si svolgono secondo uno schema consolidato (appaiono chiaramente scritte a ritroso, costruite a partire da un finale che si vorrebbe a effetto, finendo di frequente in tal modo con il creare dei buchi logici e delle incoerenze nel flusso narrativo) e seguendo un copione divenuto grosso modo fisso (c’è un protagonista della storia, e poi nella storia viene inserito in qualche modo Tex, da solo o con Carson; la storia funzionerebbe sempre meglio con un co-protagonista diverso da Tex e creato appositamente). In questo schema, si inserisce ora Ben il Bugiardo, che ci piacerebbe aprisse alla speranza di un qualche miglioramento/ravvedimento.
Il Texone n.41 aderisce largamente al classico canovaccio di Ruju dianzi descritto, discostandosene tuttavia in modo sottile ma determinante.

La storia dell’albo pare nascere come sempre o quasi dalla sua scena finale, sulla quale l’autore pone via via il racconto che dovrà condurre alla sequenza conclusiva e del pari vi è un personaggio, l’eponimo Ben del titolo, che quanto meno in apparenza si pone al centro della trama relegando Tex (qui con Carson) in posizione più defilata.
In realtà, se quanto al primo aspetto Ruju non ha effettuato diversioni, il personaggio di Ben, pur strategico, non mina la centralità di Tex e neppure assume la funzione di scudiero o “pard di complemento”: questa è contemporaneamente una “storia di Tex” e una “storia di Ben”, e Ruju se la gioca abbastanza bene con i due registri. Il racconto non è segnatamente brillante. L’autore si appoggia senza grandi guizzi d’ingegno a uno dei topoi letterari, non esclusivi del West, più classici che vi siano: il percorso di riscatto di un codardo. Il tipo di soggetto, per capirsi, che in mani sapienti ha prodotto capolavori cinematografici come Le quattro piume di Zoltan Korda del 1939 o Un dollaro d’onore di Howard Hawks del 1959. A livello di trama c’è qualche falla logica (alla fin fine: cosa vuol fare davvero Tex con la banda dei fratelli Puentes?) – e soprattutto non si affranca dal difetto peggiore del Tex di questi anni: la prolissità. Per riempire le duecentoventi tavole del texone Ruju manda in giro senza costrutto i personaggi, fa far loro cose di dubbio senso, ne materializza i pensieri spesso rallentando senza necessità il ritmo narrativo. O meglio: dovendo necessariamente portare alla lunghezza di duecentoventi tavole una storia che sarebbe stata perfetta per una quarantina o persino cinquantina di meno.

L’autore si riscatta però ampiamente nella gestione dei personaggi, a partire da un Tex tutto sommato corretto, che, pur seguendo uno dei più balzani cliché recenti secondo il quale Tex si fa prima sparare addosso e soltanto poi risponde al fuoco, è il motore degli eventi e il solutore finale. L’aspetto migliore del Tex di questa storia è il modo in cui Ruju lo fa rapportare al “suo” protagonista, Ben O’Leary: Tex appare a un tempo divertito dal giovane e troppo preso dagli eventi che incalzano per dargli granché spago, comprensivo per i suoi difetti e paterno nell’incoraggiarlo ma anche nel cercare di dissuaderlo dal fare cose oltre la sua portata, e alla fine riconoscerà che il giovane ha saputo emendarsi degli errori compiuti, e che sicuramente è degno della sua considerazione – e, chissà, persino di quell’amicizia che Ben andava millantando: Tex, insomma, è giustamente Tex nei confronti di una comparsa della sua vita con ambizioni di poter rappresentare un qualcosa di più.
Ben il bugiardo poteva facilmente essere un personaggio antipatico o stucchevole, e sebbene la sua figura non sia esente da una certa eccessiva “petalosità” (se mi è consentita una variazione su un termine che fece chiacchierare qualche anno addietro), Ruju ha saputo tratteggiarlo con affetto e sobrietà al contempo, senza esagerarne i tratti più teneri né costruendogli un percorso di riscatto eroico che suoni irrealistico: Ben è un uomo ordinario che, spinto da forti motivazioni, arriva a compiere atti che di norma non si sarebbe sognato di compiere.

Detto di un Kit Carson non particolarmente pervenuto, ma che neppure viene trattato da pezza da piedi o anziano mezzo svanito come accade di frequente da diversi anni, meritano considerazione per come sono stati raffigurati anche gli altri attori importanti della storia. Ruju delinea i due fratelli Puentes, Carlos e Ramon, facendone due individui chiaramente distinti e ciascuno con una propria spiccata e realistica personalità; così come di Angela e Jimena compone i ritratti contrapposti di due donne volitive, energiche e coraggiose, due realistiche donne della dura frontiera americana, ma non le spesso ridicole “superfemmine” con le quali da anni gli autori ammorbano le pagine di Tex (per tacere di quelle di Zagor). Infine, il più riuscito del mazzo è probabilmente il ritratto di Gato, il tagliagole Comanche. Ruju ne sbozza con sorprendente cura la personalità, facendo di una figura altrimenti di contorno la miniatura di un individuo decisamente non banale: un feroce scannacristiani che però, da manuale verrebbe da dire, si rivela sensibile alla variante di quei racconti attorno al fuoco che erano il pane degli uomini e donne delle società orali, preletterarie con la quale la magia affabulatoria della parlantina di Ben lo irretirà. Scaltro e ingenuo allo stesso tempo, in un film Gato sarebbe un buon candidato all’Oscar per il miglior attore non protagonista.
In sintesi, questo albo gigante del 2025 non è sicuramente un capolavoro, ma è una storia superiore alle sue pecche evidenti, e che a onta di tali pecche si risolve in una lettura piacevole con molti spunti di genuino interesse. Un racconto che non definiremmo pienamente texiano nello spirito, ma che dà dell’universo di Tex una lettura accettabile nella sua leggerezza.