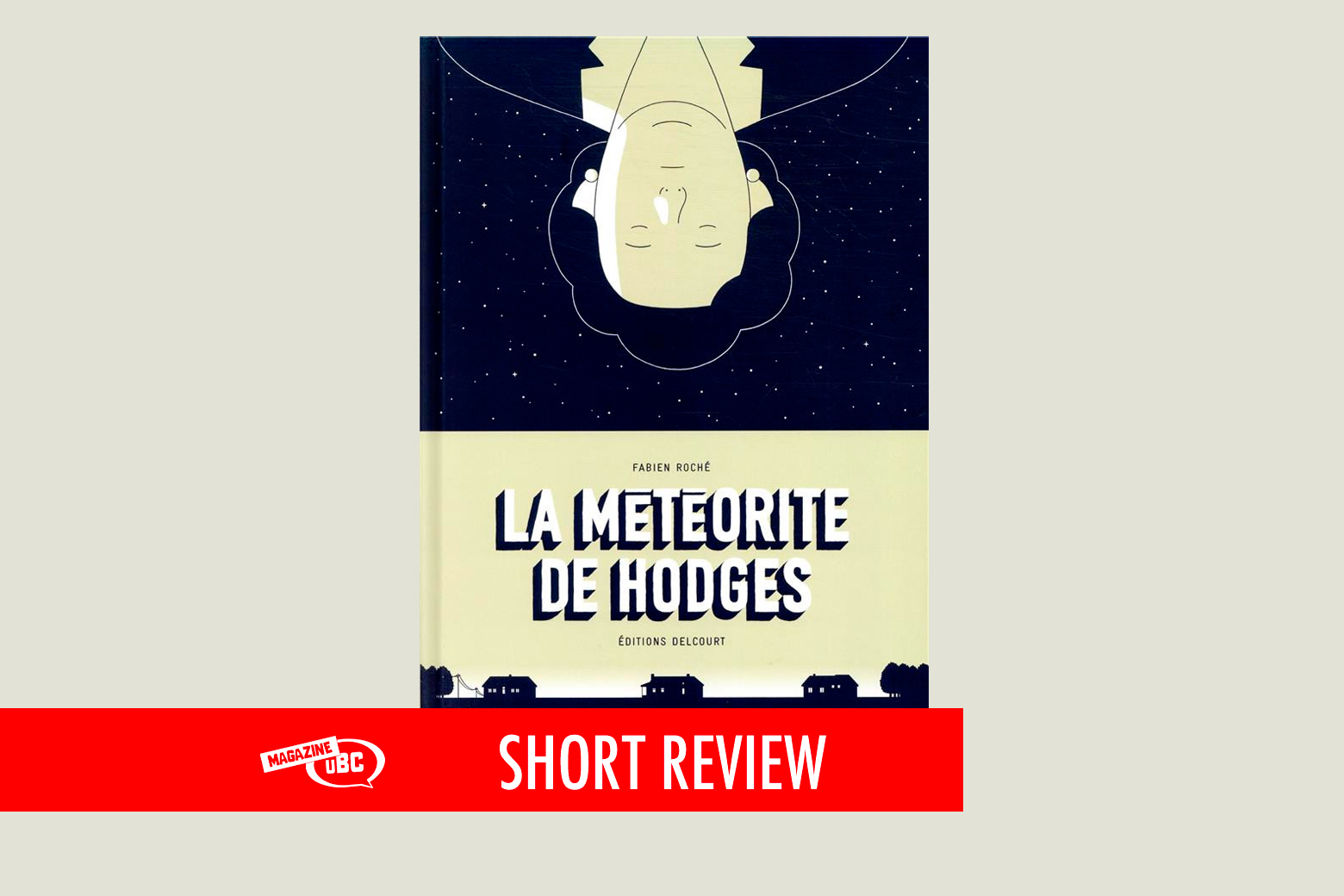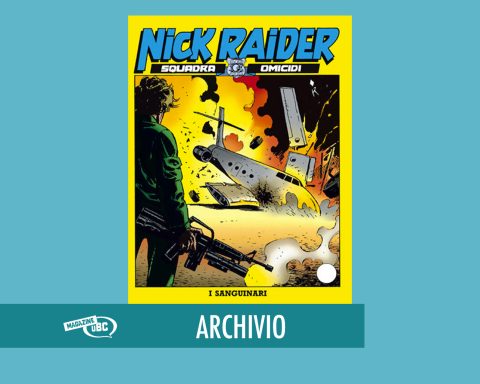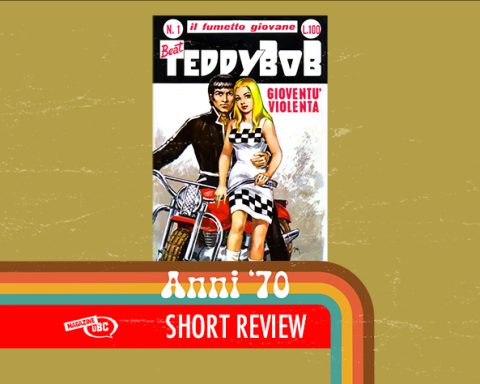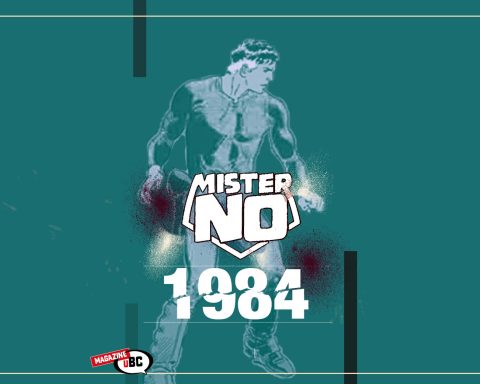La météorite de Hodges (Delcourt 2021, non tradotto per il mercato italiano), opera prima di Fabien Roché, a tutt’oggi resta anche un’opera unica. Ed è un vero peccato. La filiazione da Chris Ware è talmente manifesta da rendere superfluo il dichiararla; ma porsi sulle spalle dei giganti è forse una colpa?
Partendo da un fatto di cronaca (l’impatto accidentale di una scheggia di meteorite con l’unico essere umano ad averlo subìto, la signora Hodges), Roché dilata la dimensione temporale su tavole di grande formato – 25×34 cm – tramite una struttura modulabile basata su un tracciato di sette strisce ciascuna composta da cinque vignette, dirigendo la lettura non sulla singola tavola ma sul libro aperto. Frazionando il tempo Roché moltiplica i punti di vista, visualizzando la cacofonia che ne deriva attraverso il vecchio procedimento della sovrapposizione delle nuvolette, al quale la linea chiara derivata da Ware (ma anche Tomine, Jacobs e Hergé) aggiunge dolcezza e straniamento. Lo scopo non è solo quello di raccontare l’evento in sé, ma da quel ch’esso genera comporre un ritratto lucido della società americana degli anni Cinquanta, precorritrice della nostra attuale.
Tutto questo sino alla doppia pagina finale, nel quale la vita della signora Hodges letteralmente esplode attraverso la visione esagonale degli occhi d’una mosca. Lo sguardo invertito, dal significante (l’essere umano) all’insignificante (la mosca) esplicita allora l’orizzonte filosofico nel quale si dipana il racconto, dove la sovraesposizione delle voci non diventa coro, ma sminuisce la funzione catartica che la rarità dell’evento possiede in nuce. Non è forse quel che accade oggi?