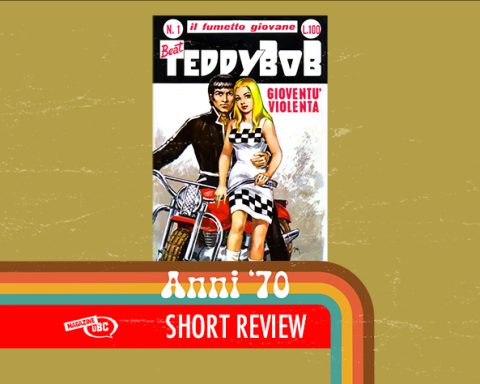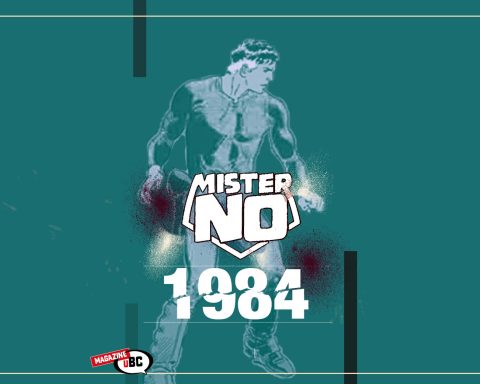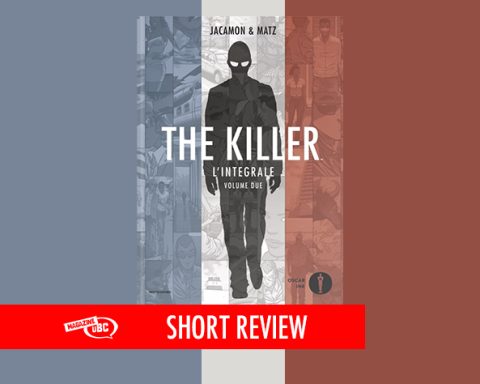Ineluttabile botta e risposta con l’autore sul senso dei suoi Ghost Finders…
Ineluttabile botta e risposta con l’autore sul senso dei suoi Ghost Finders…
Tutti i Link di Manfredi: intervista all’autore di Gordon Link!
Legami con l’aldilà, certo, ma soprattutto con i fantahorror di serie zeta e con l’arte alta, con la musica, il teatro e la televisione. Legami che dieci anni fa ci hanno legato alla sua irriverente banda di scovaspettri e, non ultimi, legami con ciò che oggi è Magico Vento…
Come sono nati i Ghost Finders? Quale fu l’input di partenza?
Italia Uno (la rete televisiva) aveva acquistato i film dei Ghostbusters e da qui era nata l’idea di una serie televisiva italiana sullo stesso tema. Poi, però, il progetto abortì e mi restarono in mano cinque o sei sceneggiature inutilizzate. Casarotti, il boss della Dardo, mi propose di trasformarle in fumetto e la cosa mi interessò subito: i fumetti non hanno problemi di costo e di effetti speciali e lì avrei potuto esprimermi più liberamente. I personaggi fondamentali restarono quelli (pur cambiando nomi, ambientazione e “taglio” delle storie) e cioè Gordon Link , un cacciatore di spettri vanesio e un po’ yuppie; la sua ex moglie Jessica (poliziotta sexy e aggressiva che nella serie televisiva avrebbe dovuto essere interpretata da Alba Parietti, non ancora famosa) e i suoi tre collaboratori e amici che rappresentavano tre diversi modelli “giovanili”: il maniaco dei computer e della tecnologia, un’improbabile segretaria dark e decisamente svanita, e un simpatico “palestrato”. Poi c’era Kalimba, una pianta carnivora – ispirata alla Piccola Bottega degli Orrori di Roger Corman – e Puki, un animaletto buffo che sembrava un Critter. Il tono, nella versione a fumetti, divenne molto più demenziale ed esplicitamente trash (anche se questa definizione all’epoca non era ancora “codificata”): l’immaginaria città di ambientazione (Hinterland) era praticamente una discarica a cielo aperto, i fantasmi erano residuati industriali, nuvole di smog materializzate o “mostri” partoriti dalla televisione.
Le citazioni mischiavano riferimenti “alti” (per esempio a Dalì o ai “Cadaveri squisiti” dei Dada) a rivisitazioni di spassosi film di serie Z tipo “Pomodori Assassini” (“Attack of the killer tomatoes” di John De Bello). Col tempo, capii che questa piega decisamente umoristica (tra l’altro particolarmente adatta a Della Monica che era cresciuto alla scuola di Alan Ford) non poteva avere un grosso pubblico, perché i lettori dei fumetti subivano l’affascinante influsso di Dylan Dog e preferivano storie più drammatiche. Cercai così una maggiore varietà di toni e sfumature, ma ormai i nostri lettori erano calati a 25.000, il che non era affatto disprezzabile, senonché l’editore non si trovava più nelle condizioni di continuare, anche perché la serie (tra speciali e supplementi) era molto onerosa.
 Chi incoraggiò maggiormente l’operazione? Tu, Casarotti, Della Monica o chi altri?
Chi incoraggiò maggiormente l’operazione? Tu, Casarotti, Della Monica o chi altri?
Casarotti sostenne l’operazione con grande entusiasmo, del resto i primi eccellenti risultati di pubblico gli diedero ragione. Però avremmo dovuto aspettare qualche tempo prima di uscire in edicola: invece ci presentammo subito ai lettori con un solo numero pronto che restò in edicola un paio di mesi per permetterci di completare il secondo, e poi avanti così, di corsa, mese per mese, nello sforzo di essere puntuali con le uscite. In queste condizioni era molto difficile garantire un alto livello di qualità: all’inizio Della Monica era l’unico disegnatore a disposizione, e la casa editrice aveva due soli redattori che si occupavano anche di altre serie e dunque non ce la facevano a correggere le tavole e tantomeno a farsi carico delle rubriche.
Io dovevo occuparmi di tutto e con pochissimo tempo a disposizione, scrivendo le sceneggiature al volo. Della Monica, che aveva nel frattempo presentato un suo progetto di serie “gialla” a Casarotti e poi era stato dirottato su Gordon Link, era costretto a lavorare a ritmi davvero impossibili, per sfoderare una storia al mese, quindi disegnando una tavola completa al giorno! Le cose migliorarono quando si aggiunse Emilio Cecchetto, un disegnatore dal segno affascinante e di una rapidità veramente marziana. Purtroppo però venne a mancare, improvvisamente, da un giorno all’altro.
Insomma, ci siamo trovati a lavorare tra mille difficoltà e quando ormai avevamo sufficienti disegnatori e anche qualche nuovo sceneggiatore – come ad esempio Marcello Toninelli che scrisse un’ottima storia su Johnny Walker (sì, proprio il personaggio che sta sull’etichetta dell’omonimo whisky) – o Claudia Salvatori, che veniva da Topolino dove però non poteva sfogare certe sue inclinazioni ai generi estremi (come appunto l’horror, il thriller e il demenziale), ormai era troppo tardi: la serie non poteva più sostenersi. Avremmo anche potuto trasferirci presso un altro editore (le offerte non mancarono), però sia io che Della Monica non ce la sentimmo di affrontare un’altra avventura spericolata. Con Casarotti c’era stata una grande complicità e molto divertimento, con altri forse quell’atmosfera si sarebbe persa e sarebbe rimasta solo la fatica.
 Quando hai ideato Jack Condor, alias Lee Van Cleef versione zombi, avevi già in mente, seppur in fase embrionale, Magico Vento? O era il tuo primo approccio con il western-horror?
Quando hai ideato Jack Condor, alias Lee Van Cleef versione zombi, avevi già in mente, seppur in fase embrionale, Magico Vento? O era il tuo primo approccio con il western-horror?
Era il primo approccio, certo, e sempre di genere demenziale. Mi aveva divertito il pistolero zombi del film “La casa di Helen” (“House II: the second story” di Ethan Wiley, 1987), che aveva tra l’altro anche un cavallo zombi. Mi era venuta in mente una scena in cui il pistolero zombi sparava col dito invece che con la pistola, infilzandosi un proiettile nel palmo e puntando l’indice proprio come fanno i bambini quando giocano ai pistoleri. Non c’era molto altro.
Magico Vento nacque da riflessioni molto più ponderate. Avevo avvertito, come ho detto, che i lettori inclinavano decisamente al drammatico e dunque pensai a un personaggio epico e western, ma afflitto da una sorta di schizofrenia e con la mente sconvolta dall’abuso di droghe indiane: ammazzava gente a valanga, ma senza rendersene neppure conto, scambiando i suoi nemici per mostri spaventosi, e quando poi realizzava cosa aveva fatto, vomitava e riprendeva a drogarsi. Avrebbe dovuto avere i capelli precocemente bianchi. Inoltre, pensate un po’, era muto! Ero consapevole che un personaggio connotato in modo così radicale mi avrebbe creato molte difficoltà e non solo sul piano narrativo… ma allora, come ho detto, nuovo com’ero al fumetto, ero convinto di potermi permettere di tutto e di poter correre qualsiasi rischio. Solo l’esperienza alla Bonelli, con Dylan Dog e Nick Raider, mi ha permesso di capire quanto fosse cambiato in profondità il pubblico dei fumetti e in genere il mercato editoriale di comics che non assecondava più i gusti estremi e dissacratori della fine degli anni Settanta. E poi, nel frattempo ero cambiato anch’io, e attratto dalla spiritualità lakota e dal mondo magico degli indiani, trovai più stimolante e innovativo creare un eroe sciamano.
Il tuo rapporto con i lettori è particolare, rispetto a quello di molti altri autori di fumetti: ti piace raccontare molto delle tue creature, ti piace ricordare i testi a cui ti sei ispirato, e consigli spesso (sempre!) letture di approfondimento sui vari argomenti trattati. Qual è il tuo rapporto con i lettori e con il pubblico in generale?
Io ho cominciato come cantautore e l’esperienza del palcoscenico mi ha marchiato. Solo la musica e il teatro possono darti il rapporto diretto e immediato con il pubblico, di cui puoi avvertire le emozioni, la tensione e magari anche l’insoddisfazione, in diretta e senza mediazioni. Quando invece si fa cinema, letteratura, fumetto, questo rapporto si perde. Il pubblico diventa una folla anonima, misurata in numeri: se sono tanti, vuol dire che quello che hai fatto è piaciuto, se sono pochi vuol dire che non sei riuscito a raggiungerli e ormai non puoi fare più nulla per correggere il tiro. E poi, pochi o tanti che siano, non c’è ricerca di mercato che possa dirti chi sono, se ti hanno seguito per passività, per moda, o per noia, oppure se quello che hai cercato di seminare ha prodotto qualche emozione in loro. L’unico modo per capirlo è attraverso le lettere, l’unico modo per conoscerli almeno un poco è rispondere a tutti, confrontare le tue idee con le loro e imparare a leggere anche tra le righe i loro stati d’animo. Ne resti influenzato in un modo molto particolare: non ho mai trovato un solo lettore che mi suggerisse uno spunto di storia stimolante, che non mi sarei mai immaginato, ma ho trovato spesso lettori diversi dai cliché del lettore-tipo e anche del giovane-tipo e dell’italiano-tipo.
La realtà è molto più varia e mescolata di come tendiamo a interpretarla. I lettori sono tutto tranne che una massa di cani ammaestrati che risponde a comando alle sollecitazioni dell’autore professionista e convinto d’essere un gran furbacchione. È proprio come in palcoscenico: a volte non capisci perché una battuta che ha funzionato per un sacco di sere, quella sera lì (anche se non l’hai detta male) non ha fatto ridere nessuno. Pensi d’aver toppato, però poi vengono lo stesso a trovarti dietro al palco, per dirti che si sono divertiti moltissimo, solo che in quella zona lì non è costume sbracare emotivamente davanti a tutti e ciascuno preferisce ridere dentro di sé. Più spesso accade il contrario: che cioè la gente applauda per gentilezza o magari per simpatia, ma che se ne esca molto poco convinta, perché in realtà da te si sarebbe aspettata molto di più. Le lettere hanno il vantaggio di aprirti ogni tanto qualche squarcio di vita dei singoli lettori, che finalmente vengono fuori come persone e non come semplici “fruitori”.
 Nel tuo fumetto anticipi l’attuale situazione sociopolitica europea. È una cosa: a) su cui contavi; b) che non credevi; c) che temevi; d) ecchissene…
Nel tuo fumetto anticipi l’attuale situazione sociopolitica europea. È una cosa: a) su cui contavi; b) che non credevi; c) che temevi; d) ecchissene…
Lo avevo già fatto nel mio romanzo Trainspotter e nel successivo Il peggio deve venire. Non volevo dare un giudizio sull’Europa, però, ma su una tendenza al peggioramento inesorabile delle condizioni di vita e della situazione economica e politica, in netto contrasto con certo facile e propagandistico ottimismo degli anni Ottanta, di cui oggi viviamo le ultime e farsesche propaggini. A confronto della situazione sociale descritta in quei miei romanzi, la Hinterland di Gordon Link era molto più vivibile, animata e giocosa. C’era anche una certa sottolineatura della multietnicità, della commistione di tradizioni diverse, e di quanto di festoso e di allegro questo avrebbe portato (anche tra apparenti cataclismi). Insomma c’era più speranza. Forse è per questo che, paradossalmente, Gordon Link si gusta meglio oggi che quando è uscito. Allora questi temi erano troppo in anticipo, cominciavano appena ad affiorare.
Il tuo alter-ego texano, per tematiche e per versatilità creativa, sebbene più votato ai romanzi che ai fumetti, è Joe Lansdale. Cosa pensi di quest’autore, del suo modo di narrare il West, non solo orrorifico, ma spesso anche ricercatamente lercio e scorretto ai limiti della nausea (vedi Jonah Hex e Dead in the West)? Cosa vi accomuna e cosa vi divide?
La risposta è implicita in quanto detto prima. Magico Vento non dimentica mai la spiritualità e non c’è indulgenza e compiacimento verso i massacri. Il mio è un fumetto post-anni Settanta e non mi interessa più sfogare la mia natura anarchica nel “gore”. D’altra parte, anche nelle mie canzoni di fine anni Settanta c’è sempre stata molta tenerezza e ironia. Non sono mai stato un punk.
Certo che investire in strabilianti gadget come l’audiocassetta e lo spillatone formato A4 fu una grande soddisfazione per l’aficionado, ma anche un bel rischio per l’editore! Chi suggerì tali idee, magiche e folli allo stesso tempo? Cosa ne pensi di quelle operazioni?
Le suggerii io, perché mi parevano corrispondere a una richiesta dei lettori: anche Topolino in quegli anni proponeva gadget a raffica. Le operazioni di per sé furono condotte con responsabilità e non furono certo quelle a portare al crack l’editore. Anzi, credo che Casarotti sarebbe d’accordo nell’ammettere che la sua chiusura non dipese esclusivamente da Gordon Link, ma da molti altri fattori, per esempio le (queste sì) molto onerose ristampe di vecchie serie (tipo Gim Toro) da parte della casa editrice, pubblicazioni che accumularono migliaia di resi in magazzino, contribuendo a prosciugare le risorse.
Magia Rossa, Cromantica, Ultimi Vampiri. Quanto dei loro contenuti hai travasato nelle avventure dei Ghost Finders? Dove e come possiamo recuperare i tuoi romanzi?
Nessun travaso. Io tengo a separare bene i campi, altrimenti ne nascerebbe – se non altro nella mia testa – una confusione indescrivibile. I miei romanzi sono esauriti da tempo e non si trovano neppure presso i remainders. Con calma, verranno ristampati nell’intervallo tra un nuovo romanzo e l’altro. Per adesso, chi volesse leggerli può trovarli gratis in qualsiasi biblioteca. E frequentare le biblioteche fa sempre bene.
Ci puoi dire i massimi e i minimi di vendita della testata?
Se non ricordo male il primo numero di Gordon Link vendette 80.000 copie e l’ultimo era poco sotto le 25.000, come dicevo in precedenza.
 Tutte le iniziative parabonelliane degli anni Novanta sono fallite, ad eccezione di Lazarus Ledd (e di alcuni Eura, Dago e Martin Hel). Perché, secondo te?
Tutte le iniziative parabonelliane degli anni Novanta sono fallite, ad eccezione di Lazarus Ledd (e di alcuni Eura, Dago e Martin Hel). Perché, secondo te?
Mercato asfittico, autori inesperti, editori temerari? Bonelli ha un mercato più largo, paga meglio i disegnatori e vanta una robusta ed efficiente redazione. Basta questo a rendere più difficile il lavoro degli altri, anche perché troppo spesso questi altri preferiscono imitare Bonelli piuttosto che battere strade nuove e diverse. L’omologazione sull’avventura e sul formato bonelliano (che tra l’altro poco si presta a una vera diffusione internazionale) non giova a nessuno, tantomeno a chi non l’ha inventato, ma semplicemente subito. Diabolik e Topolino, tanto per fare due esempi – ma si potrebbero citare anche Lupo Alberto, oppure i manga – hanno stili e formati diversi e hanno saputo difendersi benissimo nelle cicliche crisi di mercato, forti di un loro carattere originale.
E oggi vedi gli spazi per un’operazione coraggiosa ai limiti dell’incoscienza come fu la vostra?
Gli spazi per l’incoscienza ci sono sempre, ma devono inventarsi il loro “medium”. I media tradizionali tendono a produrre cose tradizionali. Per cose nuove ci vogliono mezzi di diffusione nuovi.
Oggi come oggi, secondo te, nelle edicole c’è un “Gordon Link” a cui varrebbe la pena dare un’occhiata?
Non lo so. Purtroppo i miei attuali ritmi di scrittura non mi permettono di leggere molti fumetti. Questo è un grosso limite, ma come si fa scrivendo tutti i giorni fumetti dalla mattina alla sera a leggere fumetti nel tempo libero? Non si può proprio. Bisogna leggere e vedere altre cose, se no – dopo un po’ – finisci che pensi per vignette, o più esattamente: ti ritrovi a vignettare persino i tuoi pensieri.
E tra i giovani scrittori e disegnatori emergenti o ancora non emersi, chi vedresti bene coinvolto in una simile iniziativa? Insomma ci sono autori nuovi che ci segnaleresti volentieri?
Tra gli autori nuovi mi piace molto Alessandro Bilotta e in particolare il suo coraggiosissimo personaggio di Maraviglia.
Negli ultimi anni sono usciti ben pochi horror degni di questo nome, caciaroni e divertenti, mentre negli anni Ottanta e Novanta ne fummo sommersi. Tolto il solito John Carpenter (sbarcato addirittura a Venezia, tale e tanta era la rarità che andava a presentare, “Fantasmi da Marte”) e qualche Wes Craven, cosa ci resta? È finito il tempo dello splatter delle porte da non aprire, delle maschere da hockey al campeggio di venerdì e delle varie Case, con o senza cancelli. Anche in Italia mi sembra che il post-Argento/Fulci/Soavi sia piuttosto duro. Cosa succede all’industria del terrore? Non mi dirai che “realmente” la quotidianità ha superato la fantasia in quanto a perversione?
Attualmente l’horror è morto, su questo non c’è discussione possibile. È persino più morto del western, che è tutto dire… In genere, le resurrezioni dell’horror sono state sempre svolte di linguaggio: quando andava l’horror cartoonesco del neo-gotico, quello realistico non funzionava più; viceversa, dopo un periodo di dominio del finto e del “mostruoso”, sono le paure quotidiane a risvegliare il genere. Oggi subiamo il trionfo e insieme il declino dell’effetto speciale.
Cose magari senza troppo pretese, come Blair Witch Project, segnalano che sarebbe ora di ricominciare da zero, di mostrare meno, di produrre magari più poveramente, ma con maggiore “credibilità”. Quanto a me, se c’è una cosa che rimpiango, è il cinema visionario, cioè l’horror più delirante e sotto sotto “mistico”. Ma anche questo “ritorno” deve trovare la sua rinnovata chiave espressiva, la visionarietà non può più essere raccontata nei modi espressivi dello Jodorowsky di “El Topo” o della “Montagna sacra” (per citare un autore, anche di fumetti, che continuo ad amare molto).
Pagina precedente: la presentazione di Gordon Link